L’ebreo inventato
AA.VV.
A cura di Raffaella Di Castro e Saul Meghnagi
Giuntina euro 18
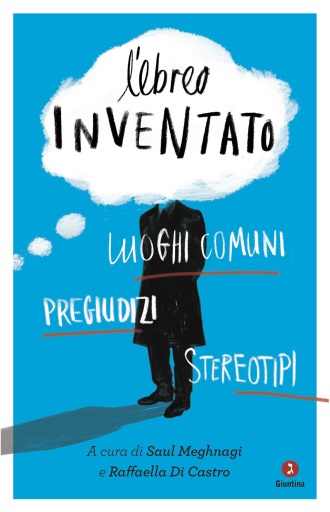
La copertina (Giuntina ed.)
A chi non è capitato, in contesti lavorativi o conviviali, di ascoltare frasi ingiuriose nei confronti degli ebrei oppure di dover controbattere ad affermazioni basate su pregiudizi o stereotipi, ad esempio “gli ebrei sono tutti ricchi o usurai” oppure “gli israeliani si comportano con i “poveri palestinesi” come i nazisti con gli ebrei”? Troppo spesso ci si trova coinvolti in discussioni accese nell’intento di spiegare le ragioni storiche alla base di taluni processi per destrutturare convinzioni perniciose e confutare tesi palesemente errate. Come reagire e rispondere dunque ad accuse e pregiudizi nei quali ci si imbatte nel quotidiano, in forme più o meno gravi, esplicite o implicite, in buona o cattiva fede? Si chiedono nell’introduzione Saul Meghnagi e Raffaella Di Castro, i curatori del libro “L’ebreo inventato”, in libreria in questi giorni per la casa editrice Giuntina. Nato da un progetto di divulgazione dell’Unione delle Comunità ebraiche e dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, il volume che raccoglie gli scritti di storici, giornalisti, filosofi, studiosi del pensiero ebraico, è dedicato soprattutto ai giovani e agli educatori ma è utile per tutti coloro che vogliono conoscere la cultura e le tradizioni ebraiche, così come la storia e nel contempo disporre di un metodo - obiettivo esplicito del libro - per rispondere a luoghi comuni, pregiudizi, credenze secondo la visione di Primo Levi che indica un percorso “senza soluzione di continuità tra banali semplificazioni, dogmi, ghetti, Lager”.
Nel libro si delineano connessioni e strade alternative a quelle ritenute “logiche” da molte persone. “Pregiudizi antichi e moderni vengono inquadrati nella loro genesi, messi a confronto con la realtà dei contesti e dei testi a cui si riferiscono, e fatti esplodere dall’interno del loro stesso punto di vista”. Il volume si apre con una premessa di Gadi Luzzatto Voghera “Antisemitismo in Italia oggi: studi e dati” in cui lo storico fornisce una interessante panoramica demografica sugli ebrei nel mondo (attualmente circa 15 milioni di persone di cui 7 milioni in Israele, 6 milioni in America e 2 nel resto del mondo), analizzando altresì come le indagini condotte con differenti metodologie abbiano messo in evidenza la presenza di un pregiudizio antisemita trasversale ai ceti sociali e alle varie ideologie politiche anche in Italia. Fra i diversi saggi in cui si articola questo volume segnaliamo quello di Saul Meghnagi in cui il pedagogista sottolinea il concetto di popolo e religione spiegando che “gli ebrei non sono definibili solo in relazione al credo religioso; sono un popolo che ha costruito la propria fisionomia culturale attraverso pratiche, rituali, usi, tradizioni, normative, sistemi di valori, modi di essere e di pensare. Sono il risultato di un costante confronto con la storia e con gli altri gruppi umani con cui hanno convissuto: nel tempo, hanno assunto lingue e modi di lettura e decodifica della realtà propri dei luoghi di residenza, a fianco a quelli della comunità d’origine. Sono l’esito di un processo di ibridazione, rimescolamento, riscrittura dei propri modi di essere e pensare”. L’idea di “elezione” è al centro dell’intervento di Roberto Della Rocca che spiega come l’”elezione” del popolo ebraico non abbia nulla a che vedere con una presunta superiorità e come sia condizionata invece da un comportamento coerente con i dettami della Torà. “L’elezione richiede dunque un comportamento corretto e meritevole, anche nei confronti dei più deboli, rendendo all’orfano, alla vedova e allo straniero quanto a essi è dovuto. La compensazione all’amore “celeste” sta nel rispondere con la giustizia terrena, qui e ora”.
Al tema usura e denaro è dedicato il saggio di David Bidussa perché con la frase spesso udita “Non fare l’ebreo, il rabbino” si evidenzia immediatamente un pregiudizio che lega l’immagine dell’ebreo alla persona attaccata al denaro, e in alcuni casi, a un usuraio. E’ un pregiudizio molto radicato che però ignora i fatti storici in quanto l’accusa di usura nasce in un contesto preciso fra il XII e XIII secolo quando il prestito a interesse a titolo privato viene svolto inizialmente dagli ebrei in quanto unici autorizzati ad assolvere tale compito. Su questa base si alimenta un luogo comune che viene a legarsi a pregiudizi antisemiti di altra natura, fortemente radicati nella cultura del tempo. Cosa si può fare per confutare questa calunnia? “Per respingere l’identificazione ebrei=denaro e usura, è necessario smontare – sulla base della storia e della geografia del fenomeno – l’idea che la costruzione del sistema di prestito e del tasso di interesse sia una caratteristica specifica dell’agire economico degli ebrei, in quanto espressione di una perversione”. Perché la pratica dell’usura non ha nulla a che fare con l’identità ma discende da una funzione sociale, dai sistemi di sviluppo commerciali e produttivi, dalle reti di scambio. Mentre Daniele Garrone indaga con un’accurata disamina storica “L’accusa di deicidio”, uno dei più forti pregiudizi antiebraici non solo in ambito cristiano che consiste nel ritenere gli ebrei in quanto tali, di ogni epoca e luogo, responsabili della morte di Gesù, con Riccardo Di Segni e Livia Ottolenghi si affrontano le “Regole connesse con il corpo e con la vita” per ribattere alla frase lapidaria rivolta agli ebrei “Avete usanze barbare, come la circoncisione” che non tiene conto del fatto che insieme agli ebrei, ai mussulmani, ai cristiani copti sono circa un terzo i maschi adulti circoncisi nel mondo. Il motivo per cui questa pratica è diffusa nell’ebraismo – spiegano gli autori – è essenzialmente religioso e segna l’appartenenza a una comunità con dei precisi impegni. Proprio in quanto elemento caratterizzante per l’ebraismo questa pratica religiosa è stata nel corso dei secoli oggetto di proibizioni e conflitti mirati alla persecuzione antiebraica e alla limitazione delle libertà religiose.
Fra i tanti esempi storici si cita il tentativo di ellenizzazione degli ebrei da parte di Antioco IV Epifane che proibì, pena la morte, tre elementi fondamentali per il mantenimento della tradizione ebraica: il rispetto di shabbat, del capo mese e, per l’appunto, la circoncisione. Più avanti nel periodo della Riforma protestante anche Martin Lutero utilizzò specificatamente la circoncisione come elemento di disprezzo nei confronti degli ebrei. Nel 2001 in Svezia sono stati varati diversi atti legislativi per regolamentare questa pratica violando di fatto la libertà di praticare la circoncisione, con un connubio di sostenitori dei diritti umani e atteggiamenti razzisti. “Dichiararsi antisionisti non vuol dire essere antisemiti” è un altro luogo comune sul quale si sofferma lo storico Claudio Vercelli. Si sente spesso usare il termine “sionismo” senza alcun riferimento storico per dare giudizi sulle forme dell’identità ebraica o sulle politiche di Israele. Questo – spiega Vercelli – rende l’antisionismo un sinonimo mascherato dell’antisemitismo, una delle forme contemporanee di pregiudizio e ostilità verso gli ebrei. Cosa si può fare per smontare questo luogo comune? “E’ fondamentale ricondurre il concetto di “sionismo” agli eventi che lo hanno generato e lo hanno visto soggetto e protagonista di un processo culturale ampio che ha coinvolto ebrei, come anche non ebrei. E’ inoltre necessario sottolineare il carattere plurale e ibrido del fenomeno:… sempre interconnesso ai contesti, alle culture e alle trasformazioni generali”. Il capitolo affidato alla giornalista Fiona Diwan si concentra su un assunto sentito nei contesti più disparati: “Gli ebrei, nei paesi arabi, stavano bene prima che nascesse Israele”. Chi ha letto i romanzi di Sami Michael o i saggi di Georges Bensoussan non può fare a meno di riconoscere la falsità di questo luogo comune perché dimentica la condizione di dhimmitudine che vide per secoli gli ebrei sottomessi ai mussulmani, indifesi di fronte a sanguinosi pogrom e umiliazioni perpetrate dai vicini arabi (con qualche rara eccezione) senza alcuna protezione da parte delle autorità governative quando non erano loro stesse ad incitare le violenze. “Come è stato possibile che si facesse largo l’idea illusoria di una “coesistenza felice” o la nozione ancor più stupefacente di “tolleranza islamica”? ….L’odio per gli ebrei (e per Israele) viene da lontano – riflette Fiona Diwan – non nasce con il 1948. Quello che vediamo oggi è l’eco di un rifiuto antico e mai sopito, che ha solo cambiato vestito”.
“L’ebreo inventato” è una raccolta di saggi, arricchita da note e da una selezione di testi per ulteriori approfondimenti, che offre a ogni cittadino gli strumenti per confutare con cognizione di causa luoghi comuni e stereotipi e spezzare quella catena di pregiudizi che ancora oggi avvolgono l’immagine del popolo ebraico. Una lettura imperdibile per comprendere che “Le sfide della democrazia sono infatti nella convivenza tra persone, comunità, religioni diverse, nel riconoscimento e nel rispetto reciproco. Il sapere, le tradizioni, le memorie, le identità non sono eredità intoccabili, ma riferimenti indispensabili per un laboratorio di confronto e crescita comuni”.
.jpg)
Giorgia Greco

