Riportiamo dal GIORNALE di oggi, 31/05/2010, a pag. 12, l'articolo di Matteo Sacchi dal titolo " Ecco la politica del terrore. L’islam fa guerra ai libri: cosa non vuole far leggere ". Da REPUBBLICA, a pag. 24, l'articolo di Vanna Vannuccini dal titolo " Tra i rocker di Teheran che sfidano il regime ", preceduto dal nostro commento. Ecco i due articoli:
Il GIORNALE - Matteo Sacchi : " Ecco la politica del terrore. L’islam fa guerra ai libri: cosa non vuole far leggere "

Valentina Colombo: Vietato in nome di Allah. Libri e intellettuali messi al bando nel mondo islamico (ed. Lindau)
L’islam ama definirsi la religione del Libro. La religione della parola scritta e certificata. Molto meno amate le immagini, anzi spesso vietate. Il raccontare è sacro, il dipingere o il suonare è spesso considerato blasfemo. Un punto di partenza tutt’altro che libertario ma che dovrebbe garantire il ruolo della letteratura, lo status degli scrittori. Dice infatti il Corano riferendosi a chi ha accesso alla conoscenza: «È per il calamo ciò che scrivono».
E per qualche secolo è stato davvero così. Almeno a giudicare dal fatto che nel X secolo il poeta Al-mutanabbi poteva permettersi versi che suonano più o meno così: «Sono forse roccia? Perché non mi smuove questo vino,/ e nemmeno questi canti?/ Se desidero del limpido vino rubro lo trovo./ Ma l’amata è perduta». Se scrivesse ora gli stessi versi, a più di mille anni di distanza, rischierebbe di avere bruttissimi guai. Per rendersene conto basta sfogliare il saggio appena pubblicato dall’islamista Valentina Colombo: Vietato in nome di Allah. Libri e intellettuali messi al bando nel mondo islamico (Lindau, pagg. 176, euro 17). Sotto l’ombra della mezzaluna gli ultimi trent’anni sono stati un vero incubo per gli intellettuali. Un incubo di cui l’Occidente riesce a rendersi conto solo quando una fatwa colpisce lo scrittore di grido con passaporto britannico, vedasi Salman Rushdie, o quando a morire sotto i colpi di pugnale degli estremisti è Theo van Gogh.
Eppure quella in atto nei Paesi islamici è una vera e propria politica del terrore. A volte a praticarla sono i governi a colpi di processi farsa, di galera e di censure. Altre ci pensano gli estremisti sgozzando gli «apostati» come agnelli. Una mattanza così diffusa e reiterata che è persino difficile fare un censimento dei perseguitati. I nomi che vedete nel grafico di questa pagina, infatti, sono solo alcuni degli esempi più clamorosi del progressivo incupirsi del controllo culturale. Se nel 1955 perché la traduzione in arabo della Divina Commedia venisse pubblicata in Egitto venne chiesto all’editore di omettere i versi dell’Inferno relativi a Maometto (ovviamente senza nemmeno mettere una nota per il lettore), venticinque anni più tardi era diventato un problema anche solo discutere di linguistica.
Nel 1980 uscì sul mercato L’introduzione alla storia della lingua araba di Louis Awadh. L’autore aveva fatto alcune innocue notazioni filologiche in cui rilevava che alcune parole del testo coranico erano legate alla lingua dell’antico Egitto. Abbastanza perché l’università islamica Al-Azhar intervenisse con tutto il peso della sua autorità per richiedere la messa al bando del volume. Il motivo? L’autore avrebbe oltraggiato la sacralità della lingua araba in quanto lingua di Dio. E se la fonetica diventa irreligiosa, figuratevi cosa può capitare a chi osa qualcosa di più. Soprattutto contando che l’Egitto è un Paese, teoricamente, vicino all’Occidente.
Ecco spiegato come è stato possibile che Mahmud Muhammad Taha, benché ottantaduenne, sia finito impiccato a Khartoum per il suo saggio Il secondo messaggio nell’Islam (correva l’anno 1985). Chiunque provi a mettere in discussione la teocrazia islamica, in Paesi in cui la pressione delle ambasciate occidentali è nulla, rischia subito grosso. E non è detto che per forza si debba ricorrere al boia: se non c’è la possibilità di una condanna a morte ufficiale possono sempre capitare sgradevoli «incidenti». Lo scrittore iraniano Ali Dashti è morto in carcere non si sa esattamente come. In gattabuia era entrato negando i miracoli di Maometto. Del resto doveva aspettarselo: nel 1980, una volta instaurata la teocrazia, Khomeini aveva organizzato il gigantesco rogo di 80mila libri.
E se i nomi degli scrittori citati sin qui vi dicono poco o nulla non stupitevi. I sostenitori dell’islam più ortodosso sanno che è strategico far loro attorno terra bruciata. A casa propria ma possibilmente anche all’estero. Tanto più che non tutti sono degli eroi votati al martirio. A volte per far paura basta meno. Quando non si arriva al dramma ci si imbatte infatti nel grottesco, in episodi surreali. Il teologo egiziano Abu Zayd, fervente musulmano ma favorevole a una certa forma di modernismo, è stato condannato per apostasia. Da allora è stato considerato dai tribunali egiziani come «giuridicamente» morto e quindi è stato chiesto anche l’annullamento d’ufficio del suo matrimonio. Ora vive in Olanda dove insegna a Leida. La vicenda potrebbe scatenare amara ilarità: il fatto che anche adesso gli convenga chiudersi bene la porta alle spalle la sera molto meno. E se lui se ne è andato, a finire nel mirino dei tribunali - in Egitto la sharia è «la fonte principale della legislazione» - sono molti degli intellettuali rimasti: nel 2008 è toccato alla regista Ines al-Dighdi, al poeta Hilmi Salim, al pensatore liberale Sayyid al-Quinmi...
Tutte persone la cui ultima speranza, quando i costi legali o il rischio che qualcuno passi alle vie di fatto diventa troppo alto, resta sempre e solo la fuga o la minaccia pubblica della fuga. Classico l’esempio di quanto ha fatto Ahmad al-Baghdadi, docente di scienze politiche in Kuwait (altro Paese che all’Occidente deve più di qualcosa). È stato condannato a un anno di galera nel 2005 per aver detto che a scuola è meglio se i bambini passano più tempo a studiare musica che a studiare il Corano. Chiedendo asilo politico ha richiamato l’attenzione della comunità internazionale. Ma più il tempo passa e meno l’Occidente è un rifugio. La presenza islamica sempre più alta porta con sé minacce potenziali, e non solo potenziali, per molti di questi «cervelli» costretti alla fuga. La somala Ayaan Hirsi Ali che collaborò con Theo van Gogh e che ha vissuto a lungo sotto scorta si è spostata negli Stati Uniti per sentirsi veramente libera e sicura. In Europa doveva vivere blindata. Nel suo ultimo libro appena tradotto in italiano, Nomade (Rizzoli), ha spiegato come in Europa un certo clima di violenza sia ormai per tutti, ma soprattutto per lei e per le donne in generale, alla «porta accanto».
L’intellighenzia e i media del Vecchio Continente, sempre pronti a gridare alla censura se qualcuno critica (non vieta) l’esposizione di un crocefisso dipinto con lo sperma, a questi allarmi sono però stranamente sordi. Deve scapparci il morto.
La REPUBBLICA - Vanna Vannuccini : " Tra i rocker di Teheran che sfidano il regime "
L'occhiello recita : " Sotto la presidenza tollerante di Khatami nelle grandi città iraniane fiorirono molte band giovanili. Con Ahmadinejad è arrivata la repressione, ma gli artisti rischiano pur di continuare a suonare e cantare ". Non è ben chiaro in base a quali elementi Khatami sia definito 'tollerante'. Permettere ciò che nelle democrazie è dato per scontato, permettere a un gruppo musicale di esibirsi, sarebbe sinonimo di moderatezza?
L'Iran di Khatami non era molto diverso da quello di Ahmadinejad perchè a controllare tutto, risultati elettorali compresi, è sempre la stessa persona, Ali Khamenei.
Ecco l'articolo:
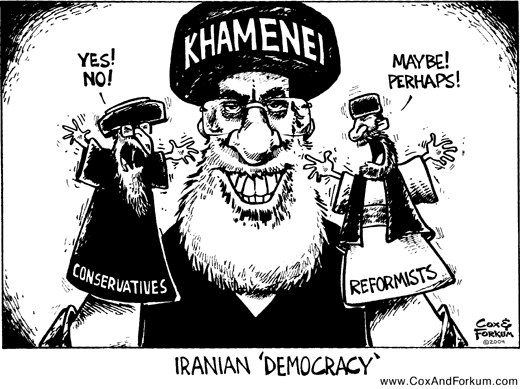
«Tra i grattacieli, l´aria è densa di poesie e di sogni. Ho sognato di fare un concerto per strada». Il ritornello de L´ultima corda, la colonna sonora di Tehran Tehran, riempie la sala del cinema Azadì. Il film racconta la storia di un gruppo rock, una storia non dissimile da quella, ormai conosciuta in Occidente, dei pluripremiati Gatti Persiani di Ghobadi. Miracolosamente però, mentre I Gatti Persiani è stato vietato in Iran e i suoi autori costretti all´esilio, Tehran Tehran è approdato sugli schermi della capitale. Nel film il gruppo rock, dopo una lunga battaglia con la burocrazia e la censura, ha ottenuto finalmente il permesso per fare un concerto, centinaia di biglietti sono già stati venduti, forse sarà la volta buona per il chitarrista e la cantante di prendere il coraggio a quattro mani e andare all´estero. Così lui smetterà di guadagnarsi da vivere con le scommesse (corre in automobile di notte per le autostrade di Teheran), e lei si affrancherà da un padre bigotto che si oppone al loro fidanzamento. A partire ci pensano da anni: «È come un dente che duole. Pensi di levartelo e poi quando il dolore è cessato rimandi». Il concerto non si farà. All´ultimo minuto, un´anonima accusa di contrabbando (il padre di lei manovra dietro le quinte) fa revocare il permesso. Il rap si avvia verso una conclusione tragica: «Chi mi segue mi ha ordinato di fermarmi/quando ho sentito la sirena urlare nelle mie orecchie distrutte/sono diventato una bomba a mano/e la mia poesia un´esplosione./Non ho mai potuto scherzare con la mia vita/né con la mia poesia./Ora sono morto e la mia morte/non è provvisoria».
Reza Yazdani, il cantante e protagonista del film (l´autrice delle parole è una ragazza, Andishé Fouladvand) quasi non crede alla sua fortuna. Spera che il suo film venga notato in Occidente, gli apra qualche chance di lavoro. La speranza di fare dei concerti in pubblico invece non ce l´ha più. L´ultima volta nell´autunno scorso, sembrava che tutto fosse pronto, ma poco prima dell´inizio il concerto fu vietato. Ogni volta è una scommessa, dice, un enorme investimento di pazienza e di tempo. Ogni singola canzone deve essere approvata dall´Ershad, il ministero per la Guida islamica, e la cosa più incredibile è che non controllano solo le parole, perfino la musica. «Mi dicono loro, che non sanno nulla di rock, come devo suonare! Sia più allegro quando canta, mi ha detto uno una volta, e aggiusti l´amplificatore, la chitarra è troppo ruvida».
La musica occidentale fu bandita in Iran dopo la rivoluzione, solo i gruppi di musica tradizionale persiana avevano qualche volta il permesso di suonare. Nell´islam lo status della musica è controverso, per alcuni è permessa, per altri è haram, illegale. Sotto la presidenza di Khatami le restrizioni diminuirono, abbastanza da permettere un fiorire di gruppi rock nei garage e nelle cantine delle grandi città, anche se i concerti in pubblico rimasero una rarità. Tutte le modeste aperture del tempo di Khatami si sono richiuse dopo che Ahmadinejad è diventato presidente. Eppure ci sono centinaia di gruppi rock in Iran. Giovani che impazziscono per gli Oasis, cantano in inglese, scrivono testi che parlano d´amore e di solitudine e di tutto quello che passa per la testa di ragazzi della loro età in ogni parte del mondo.
Senza musica non potrei vivere, dice Nilufar, che insieme a Pedram ha messo su un quintetto indie rock: una chitarra un basso una tastiera una batteria e lei che canta (soprattutto in francese, da ragazzina ha vissuto a Parigi con i genitori e non ha mai smesso di rimpiangere gli Champs-Elysées). La novità di questi ultimi anni è stata l´ingresso nella musica rock delle donne, la cui voce solista è vietata per legge. Ci sono in Iran anche un paio di rapper molto amate, Salome e Mani. Pedram canta in persiano, perché così la gente capisce le emozioni, dice. Gli accordi sono semplici ma la melodia è bella, dolente. «Perché mi hai lasciato», intona malinconica la chitarra. Ma il ritornello è furioso, aspro, cupo, disperato, a tutto volume. «Ragazzi stop», dice Pedran a un certo punto, «qui sennò arriva la polizia».
Fare musica è un´impresa rischiosa. Una settimana fa ottanta giovani sono stati arrestati per aver partecipato a un concerto organizzato via Internet, i cinque musicisti sono ancora in carcere. «Usano la musica per i loro scopi malsani», ha decretato il ministro della Cultura islamica. Nilufar e Pedran provano in una cantina insonorizzata di quattro metri per tre, nascosta tra un edificio in costruzione e le cucine di un ristorante. La prendono in affitto per un´ora la settimana. Ogni volta 20mila tuman, circa venti euro, che in Iran sono tanti. Suonano, registrano, e mettono in rete la registrazione. Senza guadagnarci un soldo, naturalmente, ma almeno in molti li ascoltano e da qualche parte nel mondo, chissà, qualcuno potrebbe accorgersi di loro, invitarli per un concerto. Cable è il nome della band.
Mi ha accompagnato alla prova un loro amico, un ragazzo che avevo conosciuto anni fa. Lui ha appena superato un esame di italiano, verrà a studiare in un conservatorio in Italia, spera in una borsa di studio. Mentre chiacchieriamo, arriva un altro ex membro del gruppo. È venuto a salutare. È raggiante. Ha avuto la green card, stanotte parte per Amsterdam e di lì per gli Stati Uniti. Uno dopo l´altro, dice Nilufar, chi può se ne va. Anche lei sogna di tornare in Francia.
Per inviare la propria opinione a Giornale e Repubblica, cliccare sulle e-mail sottostanti

