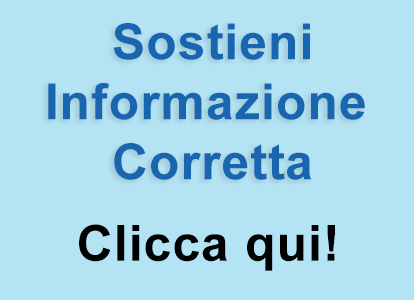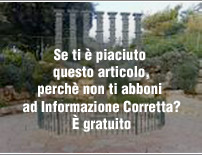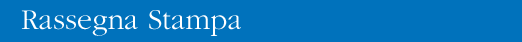Una deviazione resasi necessaria dopo l’armistizio del 1949, con l’esercito israeliano che aveva occupato il quartiere della Baqa che si era sviluppato a sud sulla strada di Betlemme fuori delle mura della Città Vecchia. Una deviazione più breve di quella alla quale si era stati obbligati durante la guerra del 1948 e negli anni a ridosso, quando per giungere a Gerusalemme bisognava puntare verso il deserto fino alle rovine del protocenobio di San Teodosio, scendere con pericolosi tornanti nel Wadi al-Nar (la Valle del Fuoco, come viene chiamata la continuazione del Cedron nel deserto), risalirne le ripide sponde fino al villaggio di Abu Dis, a sud di al-Azariyah/Betania, sulle pendici del Monte degli Olivi, e da lì rientrare nella valle di Giosafat e a Gerusalemme.
Un sacrificio necessario al quale ci si piegava di buon grado senza farsi troppe domande, anche se i chilometri da 10 diventavano 20 o 30, con una rassegnazione che sapeva di fatalismo…per uno straniero da poco arrivato come me che non riusciva a capire quella perdita di tempo inutile imposta con la forza delle armi ad una popolazione pacifica e indifesa.
La guerra del 1967 significò la riapertura della strada normale che, dopo la Tomba di Rachele, costeggiava il monastero greco-ortodosso di Mar Liyas (Sant’Elia) situato nel punto più alto del percorso sul margine di quella che era stata la no man’s land, la terra di nessuno prevista dall’armistizio del 1949, e entrava nel quartiere della Baqa diventato ebraico per l’abbandono delle case da parte della popolazione araba.
Paradossalmente, riprendeva la vita di una volta.
Per gli abitanti di Betlemme, trascorso un primo periodo di paura per familiarizzarsi con i nuovi arrivati giunti con i carriarmati e con minacciosi inviti ad andarsene gridati nella notte con altoparlanti a tutto volume piazzati sulle jeep,
Furono anni di relativa calma e sicurezza economica finché i coloni ebrei, con l’appoggio del governo, destra o sinistra in questo caso non ha importanza, semplici giochi di parole, non iniziarono le loro impiantazioni nei così detti Territori Occupati durante la guerra del 1967 per gli Arabi e il mondo civile, Giudea-Samaria per gli Ebrei.
Le vicende politiche di un mondo impazzito, ma non dall’11 settembre del 2001!, sono riuscite a dividere Betlemme dalla città di Gerusalemme per una autonomia che le sta stretta e che i tragici avvenimenti dell’occupazione e dell’assedio della Basilica della Natività nel maggio del 2002 hanno evidenziato in modo drammatico. Un taglio innaturale e forzato da cui la cittadina, forse è (e vorrei che fosse) una mia impressione, ha solo sofferto, anche e soprattutto grazie al nuovo interesse dimostrato negli ultimi anni dai samaritani di turno che vi hanno convogliato grosse somme di denaro che sono andate ad opere di pubblica utilità, ma che sono anche all’origine di una elefantiasi costruttiva inarrestabile che ha stravolto la Betlemme che io conoscevo.
Senza più rispetto per nulla, né per la vista verso est dove gli oliveti degradavano dolcemente verso il deserto, né per il centro storico dove svettavano poco sopra le terrazze delle case i campanili delle chiese e il minareto della moschea nella piazza, che erano l’unico elemento emergente. Cominciando dalla Tomba di Rachele, cambiata in fortilizio di cemento armato dai genieri dell’esercito israeliano (chiamarli ingegneri o architetti potrebbe essere offensivo della categoria!), la strada si incunea in un tunnell da slalom chiuso sui lati da palazzi che non danno respiro agli occhi fino alla Piazza della Natività.
E’ in questo tunnel di pietra che spesso si sono avventurati i carriarmati israeliani seminando distruzione al loro passaggio in una dimostrazione di forza contro la popolazione di Betlemme che come quella di Beit Sahur e di Beit Jala ha pagato a caro prezzo l’essere dall’altra parte di un confine inesistente facile rifugio per gli uni che provocano volutamente la ritorsione sparando da case non loro, visibile e indifeso bersaglio per chi risponde con la furia della potenza armata che non ha interesse a fare delle distinzioni che giustizia vorrebbe necessarie.
Il risultato di questa follia? Per chi vuole recarsi a Gerusalemme si è tornati al 1949. Bisogna prendere la strada del deserto, del Wadi al-Nar, di Abu Dis dove bisogna cambiare auto per passare il controllo israeliano e entrare a Gerusalemme.
Per i più fortunati, che vogliono continuare ad usare la strada riaperta nel 1967, i dieci minuti o il quarto d’ora di macchina che univano Gerusalemme a Betlemme possono anche diventare delle ore in una guerra logorante di nervi e di pazienza ad un doppio mahsum o punto di passaggio controllato da soldati capricciosamente comprensivi o dispettosi, gentili o ammusoniti, probabilmente non per umore personale ma per ordini che ricevono da menti pervertite che li comandano in una logica che ha solo del maniacale. Uno dei mahsum è posizionato nei pressi della Tomba di Rachele. L’altro sul punto più alto di Beit Jala dopo aver attraversato il tunnel che unisce il quartiere di Gilo all’entroterra palestinese. Tra gli autisti ci si passa la voce giorno per giorno e si decide dove tentare l’attraversamento. Più facile scendere dall’auto privata, mostrare un documento e attraversare a piedi per prendere un taxi.
A Betlemme, come intorno a Gerusalemme, il Muro prosegue un po’ capricciosamente, come l’umore dei soldati al mahsum. Sale montagne, fin sulla vetta (monumento/invenzione geniale di un artista eccentrico!), scende nelle valli attraversando uliveti e campi sventrati dai bulldozer, per bruscamente interrompersi per un buon tratto e poi proseguire, sempre secondo una logica impossibile da decifrare, cambiandosi in un reticolato opportunamente provvisto di sensori elettrici. L’impatto visivo è decisamente migliore, il risultato non credo che cambi molto.
Qualche giorno fa ne abbiamo fatto la prova. Fino a due anni fa, per visitare le rovine del monastero di epoca bizantina di Bir al-Qutt, ai piedi di Har Homa/ Abu Ghunneim, quella che per noi era la Collina di Santa Paola, si scendeva a Beit Sahur, e una volta superato il santuario del Campo dei Pastori, si prendeva il tratturo che raggiungeva Bir al-Qutt per poi ricongiungersi con la strada che saliva al vicino villaggio di Sur Baher. Il monastero costruito e abitato da monaci Georgiani nel V-VI secolo, come dimostrano le iscrizioni nei mosaici, era stato riportato alla luce dagli archeologi Francescani tra gli ulivi di un esteso uliveto premurosamente circondato da un muro di cinta provvisto di porta. Lascito generoso dei cristiani di Betlemme, le piante secolari producevano l’olio con il quale tenere accese le lampade che ardono nella Grotta della Natività.
Oggi, raggiungerlo è stata un’avventura. Giunti al Campo dei Pastori, il tratturo a noi noto cambiato in strada sommariamente asfaltata ad un certo punto cambiava direzione, inerpicandosi su una cima vicina e interrompendosi contro il Muro/Reticolato con sensori elettrici giù nella valle. L’uliveto di Bir el Qutt irrangiungibile restava isolato su in alto dominato alle spalle dalle case/bastioni del nuovo quartiere di Har Homa ancora in costruzione. Il Muro/Reticolato lo abbracciava a distanza isolandolo con una larga ansa che si incuneava nella valle. Bisognava tornare al mahsum di Betlemme, attraversare, e all’altezza del monastero di Mar Liyas prendere la strada Sur Baher-Gerusalemme del dopo armistizio del 1949, costeggiare i resti dell’acquedotto romano bizantino, come una volta…, con la sgradita sorpresa di trovarla interrotta questa volta non dal Muro/Reticolato, ma dai postumi dell’Intifada mai rimossi! Mucchi di sassi e di rifiuti con i quali gli strateghi dell’esercito israeliano avevano isolato tutti i villaggi palestinesi aggiungendo una nota di disprezzo ad una terra già desolata, stravolta e offesa dai bulldozer. Bisognava tornare indietro e prendere la nuova strada, appositamente aperta a nord del monastero di Mar Liyas sradicando altri ulivi e sventrando altre colline, che sbuca sulla strada principale subito dopo il monastero nei pressi delle rovine della chiesa della Madonna detta del Kathisma felicemente ritrovata proprio grazie a questi lavori! Siamo così riusciti a raggiungere Bir el-Qutt, ad attraversare il portone di ferro sfondato malo modo da un cingolato (resta intatto e chiuso il lucchetto!), e visitare le rovine fortunatamente in gran parte intatte tra gli ulivi.
Malgrado le difficoltà, c’è ancora chi sfida tutti i mahsum e gli umori neri o sereni dei soldati per recarsi alla Grotta della Natività che, solitaria, resta ancora l’unica vera ricchezza di Betlemme e dei suoi abitanti. Con la memoria del messaggio di pace che custodisce, quella Grotta resta l’unica vera risorsa di chi ancora spera un futuro più tranquillo in una terra da troppi anni dilaniata dall’odio che non sarà il Muro/Reticolato a cambiare in pace e serenità né per gli uni né per gli altri sui due lati di un confine assurdo che ricorda tanto la Cortina di Ferro tra le due Germanie per chi ha avuto il tempo di darvi un’occhiata.