La pubblicazione delle lettere di Saul Bellow, per ora solo in inglese, oltre ad essere un avvenimento di grande interesse letterario, offre una nuova prospettiva di indagine sul grande scrittore americano. L'articolo di Amy Rosenthal è sul FOGLIO di oggi, 18/12/2010 a pag. VI/VII con il titolo " Saul Bellow and Friends, lettere di un ebreo fortunato ", un aggettivo che ricorda le memorie di Dan Segre uscite anni fa, una autobiografia memorabile.
Ecco l'articolo:

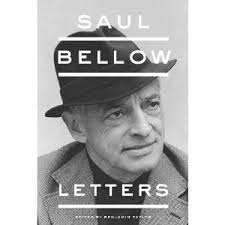
Saul Bellow, a destra, la copertina del libro
Saul Bellow è stato uno dei più grandi scrittori americani del Ventesimo secolo, vincitore del Pulitzer, di tre National Book Awards e del Nobel per la Letteratura. Alla sua morte, cinque anni fa, ha lasciato non soltanto quattordici monumentali romanzi, tra cui “The Adventures of Augie March” (1953) “Henderson the Rain King” (1959) “Herzog” (1964), “Humboldt’s Gift” (1975) “The Dean’s December” (1982) e “Ravelstein” (2000), ma anche innumerevoli lettere ad amici, colleghi scrittori, amanti, mogli e lettori che ora possiamo leggere nella nuova pubblicazione intitolata “Saul Bellow: Letters”, pubblicata da Viking e curata da Benjamin Taylor. Disegnando un affascinante autoritratto, le sue lettere offrono non soltanto un prezioso racconto autobiografico ma permettono anche di cogliere un’immagine estremamente toccante di questo brillante romanziere dotato di una verve narrativa dolce e crudele allo stesso tempo. In questo colloquio Benjamin Taylor ci parla di Bellow e delle polemiche suscitate da alcune delle sue lettere. Il lavoro di Taylor è iniziato nel 2006, un anno dopo la morte dello scrittore, quando ricevette una telefonata dal famoso agente letterario newyorkese Andrew Wylie. Taylor, membro del Graduate Writing Faculty della New School e a sua volta autore di due romanzi, inizia raccontando le sue iniziali riserve: “Mi sono semplicemente chiesto se ero all’altezza del compito. Dove si trovavano tutte queste lettere? Il giorno seguente andai alla Special Collections della Columbia University per leggere le lettere scritte a Lionel Thrilling e Meyer Shapiro; il giorno successivo alla Berg Collection della New York Public Library per consultare quelle scritte a John Cheever e quello ancora dopo alla Beinecke Library della Yale University, dove sono conservate le lettere scritte a Robert Penn Warren e Josephine Herbst. Poi iniziai a contattare singole persone ancora in possesso delle lettere loro indirizzate, comprese quelle d’amore. Capii presto che sarebbe stato un lavoro difficile e delicato ma anche entusiasmante. E mi domandai se conoscevo qualcuno con migliori capacità di conversazione telefonica di me, al quale avrei potuto affidare questo compito”. I romanzi di Bellow sono famosi per la loro capacità di fondere cultura alta e popolare, di creare dialoghi estremamente naturali fra persone colte, che non disdegnano talvolta di usare il “linguaggio della strada” ed espressioni colloquiali. Taylor annuisce e poi ci spiega l’unicità letteraria di Bellow: “Aveva una purezza di linguaggio superiore a quella di qualsiasi altro scrittore suo contemporaneo”. Ma invece di astratte spiegazioni preferisce citare un esempio concreto, tratto dalle pagine finali di “Henderson the Rain King”, che era il libro più amato da lui stesso. Il protagonista del romanzo ricorda un lavoro che aveva fatto un’estate di molti anni prima, in un luna park in qualche parte dell’Ontario, e per divertire il pubblico doveva salire sull’ottovolante insieme a un vecchio e mansueto orso bruno. “Uno straordinario esempio della grandezza di Bellow!”, esclama Taylor. Tra le 708 lettere incluse nel libro ce ne sono un paio indirizzate a un altro grande scrittore ebreo-americano, Philip Roth. “Sì – conferma Taylor –, ma l’opera di Bellow non assomiglia affatto a quella di Roth, con il quale è spesso accomunato per ragioni esclusivamente etniche. Forse Roth, il nostro più grande scrittore vivente, ha acquisito la sua stupefacente libertà leggendo ‘The Adventure of Augie March’. Ma i due avevano temperamenti profondamente diversi, e una formazione culturale altrettanto diversa. Appartengono a due generazioni differenti, e differenti sono anche i loro temi. Certo, nei loro libri ci sono gli ebrei. E allora? Faulkner e Katherine Anne Porter hanno entrambi parlato degli americani del sud nei loro libri, ma questo non ha spinto nessuno a dire che si assomigliavano”. Tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta anche Bellow, come molti altri aspiranti scrittori della sua generazione, attraversò l’Atlantico per visitare l’Europa. Tuttavia, dalle sue lettere si ricava l’impressione che fosse rimasto deluso dall’Europa, soprattutto dalla Francia. Ecco per esempio cosa scrisse al suo amico David Bazelon nel 1949: “Voglio tornare negli Stati Uniti, se non altro perché mi sento sempre più un Amerikaner. Sento moltissimo la mancanza dell’energia americana. La classe operaia che gravita attorno a Place de la Bastille è piena di vita, ma non è un granché differente da quanto si trova a Gary o Whiting, togliendo i berretti e sostituendo la birra al vino e la televisione ai concertinos”. Domandiamo a Taylor che cosa Bellow amasse e detestasse dell’Europa subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. “In quegli anni Parigi era avvolta in una cupa atmosfera ideologica e animata da un fortissimo spirito filosovietico. A differenza della maggior parte degli americani a Parigi, Bellow era in grado di seguire perfettamente il linguaggio scarno di fatti e autoingannatore di ‘Les temps modernes’ e altre cose simili. E non era certo una persona che si lasciasse abbindolare da intellettuali come Sartre o Merleau-Ponty. Da ragazzo era stato un rivoluzionario, e la sinistra comunista di Chicago gli aveva insegnato tutto quanto c’era da sapere sulla mauvaise foi”. In effetti, come lo stesso Bellow scrisse quel medesimo anno a Oscar Tarcov, un amico d’infanzia a Chicago: “Conosciamo poca gente perché davanti ai francesi bisogna fare un enorme sforzo per giustificarsi e per dimostrare di non essere un barbaro o, peggio ancora, un semplice rompicoglioni. Per quanto mi sembra di capire, ci sono in Francia due generi di persone: gli operai e tutti gli altri francesi. Gli operai sono infinitamente superiori e sono, in verità, ciò che noi in America abbiamo sempre considerato i francesi, mentre gli altri sono ciò che noi intendiamo con il termine bourgeois”. A differenza di Parigi, dalle lettere di Bellow traspare chiaramente il suo sincero amore per la Città eterna. Scrisse a Bezelon alla fine del 1949: “Magnifica Roma: un luogo molto più gentile, aperto, accessibile e umano di Parigi”. Ma, da acuto critico sociale qual sempre fu, in una lettera spedita da Positano a Oscar e Edith Tarcov nel 1950 osserva: “Qui ci sono solo i giornali italiani e per loro la catastrofe è una vecchia storia – preferiscono il gossip”. Durante i turbolenti anni di piombo dell’Italia, Bellow esprime le sue preccupazioni ad amici e familiari in visita in Italia o intenzionati a recarvisi. Nel 1978 rimprovera con queste parole il suo amico James Salter, che in quel momento stava trascorrendo un periodo di vacanze ad Asolo: “Cosa ci stai a fare in Italia, se non per fornire una tentazione a rapitori e terroristi? Lo sto dicendo anche a mio figlio Adam che il prossimo anno vuole trasferirsi a Firenze per studiare Dante e Petrarca… Gli ho inviato alcuni ritagli di giornale, ma non gli hanno fatto alcuna impressione”. In una lettera indirizzata lo stesso anno a John Cheever, il quale gli aveva domandato se avesse qualche persona da raccomandare alla American Academy di Roma, scrisse: “Non ho nessuno da raccomandare… e d’altra parte non vorrei vedere nessuno dei miei amici gambizzato”. Comunque anche Roma, come già Parigi, alla fine lasciò deluso Bellow. Nel 1981, in una lettera al suo amico Allan Bloom (con il quale Bellow tenne diversi seminari presso il Committee on Social Thought della University of Chicago, dal 1980 fino al 1992, anno della morte di Bloom) scrisse: “A Roma ha vinto Henry Ford. La storia è un mucchio di fandonie, e non la puoi nemmeno vedere per colpa delle automobili”. Ma Taylor aggiunge: “Beh, non era propriamente la Roma di Augusto, Tito o Adriano quella di cui si rammaricava, bensì la Roma di Moravia e Morante. Nel 1949- 1950 Bellow li incontrava spesso, al Caffè Greco”. Nella lettera a Bloom, Bellow racconta anche questo episodio: “Ho avuto un bruttissimo choc. Mi è stata presentata una vecchia donna dall’aspetto sciatto e con i denti rovinati, le ho detto che ero felice di conoscerla e cose del genere. Ma a quanto pare lei mi conosceva già piuttosto bene, e mi ricordò che nel 1948, quando ero ancora un ragazzo, prima che avessi scritto libri famosi, ero andato spesso a trovarla – una volta ad Anacapri. Me la sono cavata metinditendo in campo tutte le mie armi di savoir faire. La vecchia signora deve aver pensato che fossi una persona fredda e distaccata. Dopo che se ne fu andata via, appoggiata al suo bastone, domandai a Paolo Milano chi fosse. Come chi era!? Era Elsa Morante, che io avevo sempre ammirato moltissimo. Proprio lei? E mi ricordai di quanto era stata bella e prestante e di come, nel lontano 1948, ci incontravamo ogni sera all’Antico Caffè Greco per bere un aperitivo; e gli occhi mi si riempirono di lacrime”. Grande cantastorie e autentico poliglotta, Bellow, ormai quasi settantenne, nelle lettere agli amici scherzava su se stesso: “Quando mi chiedono come sto, mi viene sempre da rispondere come un romano che una volta vidi investito da una Vespa. La gente gli si avvicinò per vedere come stava ed egli disse: ‘Stavo meglio prima’. Comunque, considerando la mia età avanzata, posso dire che je me porte assez bien”. Il nome di Bellow è indissolubilmente legato a Chicago, malgrado fosse nato due anni dopo che i suoi genitori erano emigrati da San Pietroburgo a Lachine, in Québec. Quando aveva nove anni, suo padre si trasferì con tutta la famiglia illegalmente a Chicago, città che sarebbe diventata non soltanto lo sfondo di molti suoi romanzi, ma avrebbe anche esercitato su di lui una forza gravitazionale che lo attrasse per tutta la sua vita. Taylor interviene dicendo: “Beh, penso che Chicago fosse ciò che la vita offrì al ragazzo, esattamente come a Joyce aveva offerto Dublino e a Faulkner Oxford, in Mississippi. O come aveva offerto Ferrara a Bassani”. Ma Chicago non diede a Bellow anche qualcos’altro, vale a dire una via di fuga dal milieu intellettuale di New York, di cui si lamentava spesso? “Quanto alla fuga dall’intellighenzia di New York e dalle sue chiacchiere, senza dubbio Bellow accettò l’incarico alla University of Chicago almeno in parte per allontanarsi da quell’ambiente”. Nel 1956 Bellow scrisse al suo amico romanziere e critico letterario Granville Hicks: “Una delle storiche benedizioni della nascita ebraica sta proprio nella capacità di prosperare anche a fronte di un’opinione ostile”. Fu soltanto a partire da quell’anno che Bellow iniziò a parlare apertamente della sua “ebraicità”. Ciononostante, Bellow si rifiutò sempre di essere etichettato come uno “scrittore ebreo” o come un sostenitore incondizionato della causa ebraica, soprattutto dopo il 1976, l’anno in cui pubblicò “To Jerusalem and back” e vinse il Nobel. Perfettemente consapevole del problema che in quel momento si poneva per la sua carriera, Bellow scrisse a Teddy Kollek (sindaco di Gerusalemme dal 1965 al 1993): “In questo preciso momento devo decidere se diventare un derviscio ebreo o rimanere uno scrittore”. In una lettera scritta nel 1976 all’amico Owen Barfield, illustre filosofo, poeta e critico britannico, Bellow spiega così le ragioni che lo avevano spinto a scrivere “To Jerusalem and Back”: “Ho deciso, e anzi l’ho preso come un vero dovere, di scrivere un breve libro su Israele. Non mi ero mai seriamente occupato di sionismo (ossia della terribile questione del destino degli ebrei); ma dopo essere andato a Gerusalemme insieme a mia moglie l’ho per così dire scoperto, e ho cominciato a prendere coscienza della mia responsabilità riguardo ad esso. Nessuno è in grado di offrire una soluzione, ma volevo almeno presentare in chiari termini la questione di Israele a un pubblico evoluto”. Un anno dopo, in un’altra lettera a Barfield, osserva a proposito del libro: “Ha suscitato molte discussioni… Non mi importa affatto di essere attaccato. Anzi, mi fa piacere, persino quando gli assalitori sono malvagi, idioti o intrisi di ideologia”. Alla scrittrice ebrea americana Cynthia Ozick, Bellow confidò le proprie riflessioni sull’Olocausto in una lettera datata 19 luglio 1987: “E’ assolutamente vero che gli ‘scrittori ebrei in America’ (che categoria ripugnante!) non hanno saputo riconoscere quello che per essi avrebbe dovuto essere l’evento fondamentale della loro epoca: la distruzione degli ebrei d’Europa”. E Negli anni Quaranta ero troppo occupato a diventare un romanziere per accorgermi di ciò che stava accadendo. Ero concentrato sulla ‘letteratura’ e pensavo soltanto all’arte, al linguaggio, al mio sforzo per impormi sul palcoscenico americano, al desiderio di vedere riconosciuto il mio talento o, come i miei compagni della Partisan Review, alle questioni del modernismo, del marxismo, del New Criticism, o ancora a Eliot, Yeats, Proust – insomma a qualsiasi cosa tranne che ai spaventosi eventi che accadevano in Polonia. Divenuto con estrema lentezza consapevole di questo mia terribile mancanza, non sapevo nemmeno come cominciare ad ammetterla”. Sebbene abbia affrontato il tema dell’Olocausto in molte opere, in particolae “The Shawl” (1989) “Heir to the Glimmering World” (2004) e nel romanzo “Foreign Bodies”, pubblicato lo scorso mese, anche Cynthia Ozick confessa di provare analoghi sentimenti di colpa per il suo atteggiamento negli anni Quaranta: “La guerra coincise con i miei anni di liceo. Leggevo Virgilio e i poeti romantici, ed ero più felice che in qualsiasi altro momento della mia vita. La consapevolezza di ciò che era accaduto agli ebrei d’Europa si è formata lentamente. La scoperta di essere quasi coetanea di Anna Frank è stato per me un terribile choc: il sapere che mentre io passavo anni felici al liceo lei moriva di tifo ad Auschwitz”. E concorda: “La consapevolezza è arrivata tardi”. Che la condizione degli ebrei fosse costantemente presente nei pensieri di Bellow, soprattutto negli ultimi anni, è confermato da un’altra lettera scritta a Ozick nel 1989: “Talvolta penso che (se solo ne sapessi abbastanza per farlo come si deve!) mi piacerebbe scrivere del destino degli ebrei nel declino dell’occidente – o, se non ti piace la parola declino, nella lunga crisi dell’occidente”. “Herzog” è pieno di finte lettere mai spedite, e ciò ci spinge a chiedere a Taylor se c’è qualche somiglianza fra queste e le reali lettere di Bellow. “Come autore del saggio ‘Le radici del romanticismo’, Moses Herzog è un totale fallimento, e il suo saggio non vedrà mai la luce. Se tutta la storia si fosse conclusa qui, Herzog sarebbe esattamente uguale al Mr. Casaubon in ‘Middlemarch’ di George Eliot che non non riusciva a terminare la sua ‘Esplicazione di tutte le mitologie’. Invece, alla fine del libro, a Herzog è concessa una redenzione visionaria”. Taylor si riferisce qui alla sua introduzione, nella quale scrive: “Ma quando Herzog subisce l’ulteriore umiliazione di essere cornficato dal suo migliore amico, il suo blocco scompare: scopre di riuscire a scrivere, non però sul romanticismo, e si mette a scrivere lettere a ritmo frenetico Sono proprio queste lettere non spedite che salvano Herzog, una frenesia epistolare capace di trasformare – con uno straordinario rovesciamento della situazione tipico dello stile di Bellow – il fallito studioso del romanticismo nell’oggetto stesso dello studio: un autentico romantico. Che gli altri si dilettino pure con il nichilismo; per Herzog invece la vita resta quello che era stata per Keats: il valore dello sviluppo dell’anima”. Poi aggiunge: “Nessun protagonista dei suoi romanzi ha avuto una vita lunga e felice come la sua. Insomma, Bellow era un uomo davvero fortunato”. Perché? “La nostra storia letteraria è piena di persone menomate e dannate: Crane, Fitzgerald, Hemingway, Rosenfeld, Schwartz, Berryman, Lowell, Stafford, Jarrell, Cheever: il dipsomane, il folle, il suicida. Bellow non fu mai oppresso da nessuno dei loro demoni. Penso invece alla vita di Bellow come a un gioiello raro e luccicante, a una purissima pietra preziosa”. Nelle lettere di Bellow ci sono parecchi commenti su numerosi presidenti americani. Su Carter espresse critiche spietate e a Leon Wieseltier, che era stato il promotore di una lettera aperta di protesta (firmata anche dallo stesso Bellow, accanto ad altri importanti ebrei-americani come Irving Howe, Jacob Neusner e Seymour Martin) al governo di Begin per la lentezza con cui sembrava intenzionato a rispondere all’iniziativa di pace del presidente egiziano Anwar Sadat nel 1978, scrisse: “Apparentemente negli Stati Uniti non c’è nessuno capace di spiegare all’Amministrazione chi sono veramente i sauditi. Bernard Lewis sarebbe in grado di farlo, a patto che gli permettano di avvicinarsi a Jimmy e che lo stesso Jimmy non sia un bambino con problemi di apprendimento”. E nel 1980, all’amico scrittore israeliano David Shahar scrisse: “Il nostro Jimmy, come tu stesso probabilmente sai benissimo, è una disgrazia tanto per noi quanto per il resto del mondo. Non posso dire che sia la autentica causa del nostro declino, ma ne è certamente diventato il ridicolo, impotente e ripugnante simbolo”. Su Reagan, che gli conferì la Medaglia della Libertà nel 1988, diede invece questo giudizio: “Non ho mai visto nessuno così a suo agio nel proprio ruolo, che recitava con eccezionale bravura, e con la vivacità di un vero artista”. Alla domanda su quali fossero precisamente le opinioni di Bellow sulla politica americana, Taylor risponde: “Era un lupo solitario, refrattario a qualsiasi etichetta di appartenenza. Tutt’altro che un animale politico. Nulla in comune con personaggi come Orwell o Sidney Hook, o con Silone, Chiaromonte, Arendt, Isaiah Berlin e Camus. E nemmeno con Malraux. Le vere questioni che si poneva Bellow erano pre politiche e post politiche: le questioni dell’anima, una parola fuori moda alla quale era molto affezionato”. Ma negli anni Ottanta e Novanta Bellow è stato considerato un neoconservatore, malgrado avesse rapporti alquanto turbolenti con molti esponenti di questo gruppo, in particolare con il direttore della rivista Commentary, Norman Podhoretz, al quale nel 1976, dopo una negativa recensione di “Humboldt’s Gift”, scrisse: “E mi risponda anche a questo: se lei fosse stato descritto sulla rivista di qualcun altro come uno scrittore ormai ‘spompato’, sarebbe disposto a pubblicare i suoi articoli su quella medesima rivista?”. Poi, in una lettera indirizzata a Ruth Wisse nel 1991: “Anche se lei la pensa così, io non ho niente contro Commentary. Norman Podhoretz e Neal Kozodoy hanno semplicemente deciso che io non esisto. Recensiscono Gore Vidal mentre io sono completamente ignorato… Potrei facilmente rendere queste persone molto scontente facendone il ritratto. Ober es geyt mir nit in lebn (‘Ma per me non è affatto una questione di vita o di morte’). Inoltre, non mi divertirebbe per niente”. E nel 1991, a Florence Rubenfeld: “Norman era il protetto di Lionel Trilling e aveva cercato di farmi fuori (con una negativa recensione di ‘The Adventures of Augie March’). Lo dice lui stesso nella sua autobiografia”. Spiegandoci le ragioni dell’irritazione di Bellow nei confronti di Podhoretz, Taylor osserva: “Avversario di qualsiasi ismo, Bellow alla fine considerò la tronfia idolatria del potere del neoconservatorismo altrettanto sconfortante dell’ideologia liberal imperante nella redazione del New York Review of Books. La mia opinione, per quel che può valere, è che il New York Review of Books di Robert Silver rimane la guida più affidabile che possediamo nel mondo di lingua anglosassone. Quanto alla rivista Commentary, ora diretta dal figlio di Norman, John Podhoretz, basti dire che in confronto a lui suo padre era un autentico Aristotele”. Nel 1985 l’American Academy and Institute chiese a Bellow di scrivere una lettera di appoggio in favore di Isaac Bashevis Singer (vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 1978) e poi, nel 1991, un tributo in sua commemorazione. In entrambe occasioni Bellow declinò l’invito, dichiarando di non essere in buoni rapporti con Singer. Chiediamo a Taylor perché questi due scrittori capaci di parlare yiddish non fossero amici: “Amici? Oh Signore, no davvero. Singer non era affatto quel malizioso e birichino ammaliatore che mostrava pubblicamente di essere. Era un uomo animato da un fortissimo senso di competizione, propenso a disprezzare le opere di tutti i suoi contemporanei e soprattutto quelle degli ebrei. Inoltre, era stata la traduzione di ‘Gimpel the Fool’, fatta da Bellow (apparsa sulla rivista Partisan Review nel 1953), a far conoscere Singer al pubblico americano: una buona azione che Singer non gli perdonò mai”. Non è un segreto che Bellow avesse la tendenza, nei suoi romanzi, a parlare dei suoi amici, vivi e defunti. Isaac Rosenfeld, morto nel 1956 ad appena trentotto anni, fu il modello cui si ispirò per il personaggio di Re Dahfu in “Henderson the Rain King”, mentre il poeta e scrittore Delmore Schwartz quello per il protagonista di “Humboldt’s Gift”. In questo medesimo romanzo, Bellow usò un episodio della vita del suo amico David Peltz. Peltz scrisse a Bellow per dirgli che si sentiva profondamente tradito e ferito, e Bellow gli rispose con tono di rimprovero: “So bene come si fa a trasformare la materia comune. E quando opero tale trasformazione, ciò non ha per te alcun valore? Quanta gente c’è a Gary, a Chicago o in tutti gli Stati Uniti che è capace di farlo, David? Quanto a me, mi auguro che anche altri lo facciano. Anzi, ne ho un desiderio fortissimo. E anche tu dovresti averlo. Il nome di questo gioco è Dona Tutto”. E dopo una lungha tirata, concluse la lettera con queste parole: “E se tu pensi che il tuo amico Bellow, che ti ama, sia nel complesso una brava persona, e non una cattiva, ebbene che sia così. Che sia così, per amor di Dio. Lascia che io dia quel che posso, come posso”. Il personaggio principale di “Ravelstein” è ispirato al suo amico Allan Bloom, il filosofo e politologo assurto a grande fama nel 1987 con la pubblicazione di “The Closing of the American Mind”. Sembra tuttavia che Bellow, come ammise lui stesso in un’intervista del 2000 per il New York Times, abbia in questo caso superato il limite rivelando l’orientamento sessuale di Bloom. Werner Dannhauser, che è stato anch’egli trafigurato letterariamente in “Ravelstein” nel personaggio di Morris Herbst, ci dice senza mezzi termini: “Non credo che si possa giustificare ogni cosa in nome dell’arte”. Ozick, che nel 2006 ha pubblicato un saggio intitolato “Throwing Away the Clef: Saul Bellow’s Ravelstein”, non è d’accordo: “Sebbene Bellow ammise di essersi ispirato ad Allan Bloom, la cosa è irrilevante”. E spiega: “Abbiamo un romanzo straordinario e questa è la sola cosa che conta. Ecco, quando tutta questa gente che è risentita nei suoi confronti sarà morta, verrà completamente dimenticata, mentre i libri di Bellow continueranno a esistere e a nessuno importerà sapere chi era in realtà Ravelstein”. Prescindendo da questa spesso ripetuta disputa letteraria, la lettera di Bellow a Dannhauser – un ex studente di Leo Strauss e intimo amico di Allan Bloom – scritta nell’autunno del 1999, dimostra che Bellow non soltanto si preoccupava di quale fosse il suo giudizio su “Ravelstein”, ma temeva anche di perdere la sua amicizia. “So che finirò per alienarmi tutti i miei amici straussiani. Alcuni di questi posso anche permettermi di perderli, ma tu non sei fra di essi. Nel tuo caso, la perdita sarebbe molto ardua da sopportare. Rifletto spesso sul concetto ebraico di kherem, che significa scomunica. Spero che questo romanzo non sia la causa di un nostro allontanamento”. Sebbene molte persone, esattamente come Dannhauser, rimasero indignate dal fatto che Bellow avesse rivelato l’orientamento sessuale di Bloom, per Taylor si tratta di tutt’altro: “Compromettere? Ma se è colmo d’amore! Ricordate l’ultima frase: ‘Non si abbandona facilmente alla morte una creatura come Ravelstein”. Nel 2000 John Atlas ha pubblicato una biografia di Bellow nella quale lo scrittore è descritto come un egocentrico quasi patologico. Bellow commentò questa biografia in una lettera allo scrittore americano Richard Stern: “La cosa che più mi inquieta di Atlas è che esercita un grande fascino sui miei detrattori. Sembra nato apposta per compiacerli. Ecco un altro abbinamento concepito in cielo”. Per Taylor, “Atlas ha la capacità di presentare il lato peggiore di ogni cosa… Ma ciò che mi preme sottolineare, a parte il tono moralistico, sono gli errori di ricostruzione fattuale e di giudizio che deformano il libro di Atlas. Un libro che si fonda su una dozzinale intelaiatura di tipo psicoanalitico e che dovrà essere subito rimpiazzato da uno studio ben più accurato. E avverrà senz’altro così”, conclude con ottimismo. Oltre a quella di Atlas, sono state pubblicate altre due biografie di Bellow, scritte rispettivamente da Mark Harris e Ruth Miller. La nostra domanda è che cosa possono trarre i lettori di “Saul Bellow: Letters” che non traspaia già nelle sue biografie. “Questo libro fa per così dire le veci di una autobiografia. E come tutte le autobiografie, ha i suoi punti oscuri. Ma, al pari di tutte le più splendide autobiografie, offre una via d’accesso eccezionale per comprendere ‘come ci si sentiva’ a essere quel particolare individuo”. Domandiamo a Taylor quale sia la sua lettera preferita di Bellow. “Quella scritta all’inizio degli anni Novanta a Stephen Mitchell, nella quale descrive la sua scoperta del Nuovo Testamento quando ave- Un’immagine dello skyline di Chicago, la città in cui Saul Bellow ambientò molti dei suoi romanzi e che rimase il suo centro di gravità permanente va soltanto otto anni. E’ una lettera inditendo in campo tutte le mie armi di savoir faire. La vecchia signora deve aver pensato che fossi una persona fredda e distaccata. Dopo che se ne fu andata via, appoggiata al suo bastone, domandai a Paolo Milano chi fosse. Come chi era!? Era Elsa Morante, che io avevo sempre ammirato moltissimo. Proprio lei? E mi ricordai di quanto era stata bella e prestante e di come, nel lontano 1948, ci incontravamo ogni sera all’Antico Caffè Greco per bere un aperitivo; e gli occhi mi si riempirono di lacrime”. Grande cantastorie e autentico poliglotta, Bellow, ormai quasi settantenne, nelle lettere agli amici scherzava su se stesso: “Quando mi chiedono come sto, mi viene sempre da rispondere come un romano che una volta vidi investito da una Vespa. La gente gli si avvicinò per vedere come stava ed egli disse: ‘Stavo meglio prima’. Comunque, considerando la mia età avanzata, posso dire che je me porte assez bien”. Il nome di Bellow è indissolubilmente legato a Chicago, malgrado fosse nato due anni dopo che i suoi genitori erano emigrati da San Pietroburgo a Lachine, in Québec. Quando aveva nove anni, suo padre si trasferì con tutta la famiglia illegalmente a Chicago, città che sarebbe diventata non soltanto lo sfondo di molti suoi romanzi, ma avrebbe anche esercitato su di lui una forza gravitazionale che lo attrasse per tutta la sua vita. Taylor interviene dicendo: “Beh, penso che Chicago fosse ciò che la vita offrì al ragazzo, esattamente come a Joyce aveva offerto Dublino e a Faulkner Oxford, in Mississippi. O come aveva offerto Ferrara a Bassani”. Ma Chicago non diede a Bellow anche qualcos’altro, vale a dire una via di fuga dal milieu intellettuale di New York, di cui si lamentava spesso? “Quanto alla fuga dall’intellighenzia di New York e dalle sue chiacchiere, senza dubbio Bellow accettò l’incarico alla University of Chicago almeno in parte per allontanarsi da quell’ambiente”. Nel 1956 Bellow scrisse al suo amico romanziere e critico letterario Granville Hicks: “Una delle storiche benedizioni della nascita ebraica sta proprio nella capacità di prosperare anche a fronte di un’opinione ostile”. Fu soltanto a partire da quell’anno che Bellow iniziò a parlare apertamente della sua “ebraicità”. Ciononostante, Bellow si rifiutò sempre di essere etichettato come uno “scrittore ebreo” o come un sostenitore incondizionato della causa ebraica, soprattutto dopo il 1976, l’anno in cui pubblicò “To Jerusalem and back” e vinse il Nobel. Perfettemente consapevole del problema che in quel momento si poneva per la sua carriera, Bellow scrisse a Teddy Kollek (sindaco di Gerusalemme dal 1965 al 1993): “In questo preciso momento devo decidere se diventare un derviscio ebreo o rimanere uno scrittore”. In una lettera scritta nel 1976 all’amico Owen Barfield, illustre filosofo, poeta e critico britannico, Bellow spiega così le ragioni che lo avevano spinto a scrivere “To Jerusalem and Back”: “Ho deciso, e anzi l’ho preso come un vero dovere, di scrivere un breve libro su Israele. Non mi ero mai seriamente occupato di sionismo (ossia della terribile questione del destino degli ebrei); ma dopo essere andato a Gerusalemme insieme a mia moglie l’ho per così dire scoperto, e ho cominciato a prendere coscienza della mia responsabilità riguardo ad esso. Nessuno è in grado di offrire una soluzione, ma volevo almeno presentare in chiari termini la questione di Israele a un pubblico evoluto”. Un anno dopo, in un’altra lettera a Barfield, osserva a proposito del libro: “Ha suscitato molte discussioni… Non mi importa affatto di essere attaccato. Anzi, mi fa piacere, persino quando gli assalitori sono malvagi, idioti o intrisi di ideologia”. Alla scrittrice ebrea americana Cynthia Ozick, Bellow confidò le proprie riflessioni sull’Olocausto in una lettera datata 19 luglio 1987: “E’ assolutamente vero che gli ‘scrittori ebrei in America’ (che categoria ripugnante!) non hanno saputo riconoscere quello che per essi avrebbe dovuto essere l’evento fondamentale della loro epoca: la distruzione degli ebrei d’Europa”. E menticabile e impressionante”. In effetti, in questa lettera a Mitchell, l’illustre traduttore e autore di “The Gospel According to Jesus: A New Translation and Guide to His Essential Teaching for Believers and Unbelievers” (1993) non descrive soltanto la sua prima esperienza della morte ma anche la sua scoperta del Nuovo Testamento durante i sei mesi passati al Royal Victoria Hospital di Montreal, ricoverato per peritonite e polmonite: “Gesù mi travolse. Avevo naturalmente già sentito parlare di lui: informazioni marginali e negative (e perché mai avrebbe dovuto essere altrimenti?). Ma rimasi profondamente commosso dalla lettura dei Vangeli. Non fu una reazione di natura sentimentale. Non ero un tipo da lacrime. Ma dovevo passare attraverso questa crisi. Avevo preso una ferma decisione a questo proposito. Ma fui trascinato fuori da me stesso da Gesù. Gesù mi liberò da ogni vincolo con le sue opere e le sue parole. La sua morte per me fu uno spaventoso orrore. E dovetti confrontarmi con l’accusa rivolta nei Vangeli contro gli ebrei, ossia contro il mio popolo. Farisei e sadducei. Anche nella corsia dell’ospedale gli ebrei erano odiati. Il mio pensiero fu (te lo riferisco come mi venne in mente allora): come può essere colpa mia? Sono in ospedale”. Nelle “Note e Ringraziamenti” Taylor si rivolge a Rosie Bellow, nata il 23 dicembre 1999, quando Bellow aveva ottantaquattro anni: “Voglio ringraziare anche la giovane figlia di Saul Bellow, Rosie (appassionata di gatti, violinista e pensatrice di grande profondità), per l’amicizia che mi ha mostrato e per avermi rimproverato una volta che me lo meritavo”. Che cosa aveva fatto per suscitare l’ira di Rosie? Taylor ride e risponde: “C’era stato un disguido con Janis Bellow a proposito di una cena a Brookline, nel Vermont. Avevano fatto la carne alla griglia, preparato un’insalata e stappato il vino. Ma io non arrivai. Non avevo ricevuto l’invito. Il giorno dopo, quando mi recai a casa loro, Rosie, puntando il dito contro di me, esclamò: ‘Ti abbiamo aspettato e aspettato!’. Mi sono sentito terribilmente a disagio”. Ma Rosie ha certamente perdonato Taylor per questo disguido, esattamente come lo perdonerà dopo aver letto le lettere di suo padre che Taylor ha curato con grande scrupolo e attenzione. (Traduzione di Aldo Piccato)
Per inviare al Foglio la propria opinione, cliccarte sulla e-mail sottostante.






